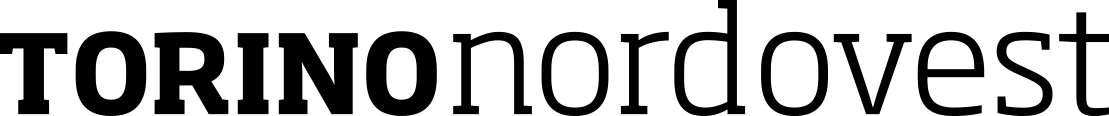Mauro Magatti
/Data
10/2012
/Titolo
Operai del terziario e nuovi ceti popolari
/Autore
Alberto Papuzzi
/Risorse
• La scheda
• La ricerca
• Il workshop di presentazione
• Il resoconto nella sezione View
/Tag
diseguaglianze, piemonte, salute, welfare
/Condividi
Se la classe operaia è protagonista, come da tempo si sostiene, di fenomeni di contrazione e di processi di disgregazione, riassunti sinteticamente nell’idea del post-fordismo, chi ha preso il suo posto nel sistema sociale? Chi sono gli eredi degli operai, nell’instabile quadro dell’attuale organizzazione della realtà italiana? Sei anni fa questi interrogativi venivano affrontati in un saggio profetico di Mauro Magatti e Mario De Benedittis, edito da Feltrinelli: I nuovi ceti popolari, sottotitolo (appunto): Chi ha preso il posto della classe operaia? Sociologo ed economista, Magatti insegna all’Università Cattolica. Lo abbiamo intervistato.
Quando oggi si parla di nuovi ceti popolari a che cosa ci si riferisce: a quali figure e quali soggetti? Può riepilogare chi sono, che fanno, che identità e prospettive presentano questi nuovi ceti?
«Ciò che caratterizza i ceti che hanno preso il posto della classe operaia sono, in sintesi, condizioni fortemente subordinate dal punto di vista lavorativo, associate a un livello di qualificazione e d’istruzione medio basso. In passato la gran parte di queste posizioni e situazioni s’identificavano con la conquista lavorativa nella condizione operaia, mentre oggi può trattarsi del magazziniere nei grandi magazzini, di chi lavora nella sanità, chi nel trasporto delle merci, insomma abbiamo di fronte un panorama di condizioni articolate, sia dal punto di vista contrattuale sia da quello dei luoghi di lavoro, e quindi molto meno significative ai fini di identificare una comune condizione, com’era quella operaia. Questi ceti sono poi anche quelli che sono stati maggiormente esposti alla trasformazione della comunicazione, e soprattutto nella fascia delle giovani generazioni sono attratti da elementi che riguardano l’esposizione mediatica, basta pensare ai social network e così via».
Quindi in questo panorama sociale, per certi versi ancora inedito, è la frammentazione e disarticolazione il dato più evidente?
«Sì. C’è chiaramente la perdita di una comune identità lavorativa, che la condizione operaia e il lavoro in fabbrica avevano invece costruito nel corso del secolo precedente, per cui prevalgono posizioni subordinate culturalmente e economicamente deboli che tendono però a essere molto anche assoggettate, come dire, all’elemento mediatico. Naturalmente ci sono poi differenze, fra nord e sud oppure per età. I più anziani hanno ancora nel loro dna l’esperienza operaia che è stata persa, mentre i giovani non hanno proprio nessuna prassi di questo modello qua».
La crisi che attraversa il mondo e colpisce soprattutto l’Europa quali effetti ha avuto su questi nuovi ceti? Sta aggravando la loro condizione? Sta aumentando la loro frammentazione?
«Allora diciamo che una delle caratteristiche della fase precedente era l’accesso di questi ceti alla fase del consumo, per dirla facile, con una soggettività che in qualche modo fosse alla ricerca di se stessa. Quindi questi ceti potevano per esempio appartenere a nuclei familiari dove entravano due o tre se non quattro redditi, che magari valevano anche poco ma messi insieme davano alla fine la possibilità di accedere anche se marginalmente al consumo, e trovare forme di soddisfazione, anche se con dinamiche di ristrutturazione relativa. Mentre oggi è chiaro che la crisi colpisce questi ceti perché rende ancora più precaria una condizione lavorativa che era già precaria quando veniva vissuta come non necessariamente negativa, poco vincolante, magari associata a un’idea di libertà. Invece adesso c’è più sfruttamento, e la precarietà è chiaramente vera precarietà. E viene messo in discussione anche l’accesso al consumo. Quindi ci si sente sotto pressione».
In una ricerca condotta da Torino Nord Ovest, Operai del terziario, vengono a galla con molta insistenza, anche nelle storie individuali che l’accompagnano, un’idea negativa, un’immagine pessimistica per quanto concerne il futuro di questi lavoratori: è la mancanza di prospettive che domina effettivamente la loro condizione?
«Allora: prima c’era una fase generale di espansione. Quindi la fragilità di questi ceti veniva contenuta e, diciamo, ricomposta in un quadro generale – sociale, economico, culturale – in cui si aveva la sensazione oppure realmente si riteneva che un po’ di benessere arrivasse comunque anche a loro e ci fosse la possibilità di farne l’esperienza. È chiaro che in un quadro generale peggiore questi elementi diventano molto più problematici. Quindi il quadro è molto più fosco per tutti e certamente c’è chi si trova senza protezione o garanzie, spesso appunto con contratti a termine o comunque precari, con prospettive lavorative molto incerte».
Una parte consistente dei nuovi ceti è costituita da emigranti: le condizioni esistenziali sono le medesime, oppure ci sono significative differenze – e se mai quali –fra gli operai del terziario di origine italiana e quelli figli dell’immigrazione?
«Il quadro che ho disegnato prima con la mancanza di serie prospettive va ricondotto principalmente ai nativi italici, mentre invece la condizione degli stranieri che sono arrivati a occupare posizioni lavorative simili a quelle di cui parlavamo prima, sarà molto diversa perché si apriva a ventaglio su molti percorsi non dico personali ma dentro una prospettiva del tutto diversa. Come sempre succede, per le prime generazioni di immigrati, l’obiettivo è quello di accedere a un benessere di cui non si dispone, raggiungere per esempio una sistemazione per la casa, raccogliere la famiglia: è una situazione molto diversa da quella descritta precedentemente. È chiaro che i due mondi sono oggi mondi che si fronteggiano reciprocamente, in molti casi possono anche entrare silenziosamente in conflitto. Quindi le due realtà vanno tenute distinte».
Fra i diversi tipi di lavoro, che riguardano i nuovi ceti – a tempo indeterminato, a tempo determinato, autonomo, atipico, fino ad arrivare al lavoro nero – quale prevale oggi sul mercato? Quale ha più spazio e densità?
«Non è che su questo posseggo dei dati per poter dire con certezza come stanno le cose. Noi sappiamo che il mercato del lavoro è in una fase di riorganizzazione e sta cominciando a subire gli effetti degli interventi di questo governo, che si è posto l’obiettivo di ridurre la grande area del precariato. In una condizione di recessione come quella in cui ci troviamo, ciò porta di fatto verso una ulteriore espansione del lavoro nero, perché è molto difficile che chi si trovava in quelle condizioni possa passare a forme contrattuali. Oltre che naturalmente verso la disoccupazione, cioè semplicemente la perdita del lavoro».
Risulterebbe che il lavoro molti di questi lavoratori avrebbero iniziato la loro attività con il lavoro a tempo indeterminato passando poi a altri tipi di lavoro, mentre uno potrebbe immaginare che si entra nel mercato del lavoro attraverso lavori di collaborazione o lavori a progetto, per arrivare a conquistare il lavoro a tempo indeterminato. Invece è il contrario, come si spiega questo processo?
«Non è proprio il contrario, diciamo che ci sono anche dei casi di questa natura. Questi casi non sono la maggioranza e sono prodotti da un insieme di combinazioni, soprattutto da due fattori. Un primo fattore è semplicemente un percorso lavorativo che incontra un licenziamento, una fuoriuscita, comunque un distacco sostanzialmente obbligato, ma dall’altra parte quello che noi volevamo sottolineare è che c’è stata una fase storica – diciamo una decina di anni fa? – in cui si era sviluppata, soprattutto nelle fasce giovanili, un’idea del lavoro fisso come una sorta di vincolo oneroso. Il mito del lavoro che si cambia, del lavoro che non dura una vita, era stato un mito che una parte di questa popolazione aveva introiettato. Insomma, si era passati dalla preferenza per la stabilità del lavoro fisso alla preferenza per una instabilità che magari appariva più libera e sembrava lasciare più spazio alle scelte personali».
Chi è Mauro Magatti
Mauro Magatti è Preside di Sociologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.