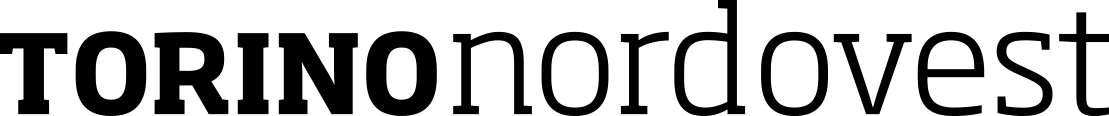Luciano Pero
/Data
1/2012
/Titolo
La moda del Wcm
/Autore
Alberto Papuzzi
/Risorse
• Il dossier con le opinioni degli esperti
• Il seminario di Luciano Pero
/Tag
industria, innovazione, lavoro, wcm
/Condividi
L'introduzione del WCM nelle fabbriche italiane in una intervista al professor Luciano Pero del Politecnico di Milano, condotta dal giornalista della "Stampa" Alberto Papuzzi.

Il World Class Manufacturing è stato definito un programma per il recupero di competitività nelle imprese con la stessa forza d’urto che ha avuto il taylorismo. Lo condivide oppure è un metodo pratico di organizzazione del lavoro senza la capacità di modellare e condizionare il lavoro e la società?
«La risposta è sì. Non ho dubbi: il Wcm può avere sul mondo industriale un impatto paragonabile a quello del fordismo. Uno potrebbe obiettare: perché ancora non lo si vede? Intanto perché ci vuole tempo per registrare dei risultati. Accadde anche col fordismo quando la Fiat lo copiò in qualche anno, mentre ci vollero decenni per segnare un’intera epoca. Inoltre tutta l’architettura, tutta l’impostazione risentono di dove il sistema è nato: nell’industria automobilistica, sia nella visione geniale di Taiichi Ohno, il padre del toyotismo, sia nell’elaborazione originale di Yamashina e degli altri giapponesi che, partiti dal toyotismo, l’hanno ulteriormente sviluppato, confezionando il primo WCM, che risale mi pare a fine anni ottanta, inizio anni novanta».
Il World Class Manufacturing è trasferibile a settori industriali che non siano quelli dell’automobile?
«Il trasferimento del WCM dall’industria automobilistica a altri settori è sicuramente possibile, naturalmente mutatis mutandis, ci vogliono degli ovvii adattamenti. Elementi fondamentali del Wcm sono la sistematicità e la ristrutturazione. Per esempio, fa propria una montagna di metodi, ormai noti, dalla qualità totale al just in time. Sono arrivati a metterne in fila duecentocinquanta, ma l’operazione chiave è stata confezionarli in una sorta di dottrina organica che si basa su dieci pillar tecnici e dieci pillar manageriali. All’interno di ogni pillar ci sono sette step, e ciascuno step suggerisce dei metodi ottimali per passare al successivo. Essendo stato concepito per l’applicazione nell’industria automobilistica, l’eventuale passaggio di questo sistema a altri settori richiederebbe un ripensamento molto rilevante».
Ma il Wcm va considerato totalmente alternativo al taylorismo oppure ne recupera dei pezzi?
«Sono convinto che i sistemi successivi non distruggono quelli che li hanno preceduti, dunque non sono mai veramente, totalmente alternativi. Semplicemente sussumono i sistemi precedenti. È una cosa un po’ hegeliana: noi diciamo che passiamo dal taylorismo al toyotismo o al Wcm, in realtà è un’evoluzione. È ovvio dunque che nel Wcm siano presenti elementi del taylorismo e del fordismo. Ci mancherebbe! Di nuovo invece c’è il contesto. Anche se è vero, come suggerisce qualche sindacalista, che nella primissima fase della lean production o forse in esperimenti fatti in Svezia ma anche in Italia, vedi le famose isole di montaggio all’Alfa Romeo di quarant’anni fa, si poteva essere più audaci. Anche oggi io penso che i nuovi ambienti industriali italiani che applicano team working, polivalenza, autodeterminazione dell’operaio, eccetera, sono sviluppati in modo ancora molto timido».
Il Wcm funziona in molte fabbriche in coppia con l’Ergo UAS, sistema di misurazione dei movimenti dell’operaio fino ai gesti non più scomponibili. È stato osservato che si tratta di un’evoluzione del metodo fordista di misurazione tempi e da parte del sindacato si avanza il dubbio che si tratti in sostanza di una forma di taylorismo, che mira sempre al controllo del lavoro. Quanto c’è di vero?
«L’adozione dell’UAS è sostanzialmente una normalizzazione, cioè significa adottare degli standard a diffusione internazionale. È anche vero che in certe postazioni prima poteva esserci una saturazione più bassa, che ora può risultare cresciuta. Non ne dubitiamo. Tuttavia la contemporanea applicazione di un sistema ergonomico elimina tutte quelle attività, quelle posizioni, quei movimenti, che risultano fatte in modo disagiato. Oggi i movimenti del lavoratore avvengono all’interno della famosa “sezione aurea” di cui parla Yamashina, quella dove si fa meno fatica, anche per l’impiego di strumenti di movimentazione. L’Ergo UAS cerca di minimizzare la fatica operaia, evitando i gesti – alzarsi in punta dei piedi o piegarsi a metà schiena – che potrebbero risultare pregiudizievoli per la salute. Quindi, anche se aumenta la saturazione, la fatica diminuisce, questo va detto».
Quanto pesa la questione del ricambio delle figure professionali? Faccio un esempio: se l’applicazione del Wcn funzionasse alla perfezione, il manutentore che interviene al volo dove si verifica un problema dovrebbe essere considerato una figura ormai superata?
«No, no. Se in una fabbrica aumenta la produttività globale, meno sprechi potrebbe anche voler dire meno persone, questo è possibile. Ma proprio per applicare il sistema al meglio ci vogliono manutentori intelligenti e esperti, perché è noto che più complicati sono gli impianti, più intelligenza si chiede ai manutentori, quindi sono figure professionali che non scompariranno mai. Quello che sparisce è lo spreco: di materiali, di energie, di tempo».
Le sottopongo una questione molto specifica: i contratti nazionali per l’industria nel nostro paese sono stati organizzati sul modello tayloristico. Ciò significa che vanno riformati? Se mai in che misura e in che direzione?
«Il principale istituto dei contratti nazionali di lavoro riferibili al mondo dell’industria è l’inquadramento unico. Gli altri istituti – l’orario di lavoro, il rapporto di lavoro, gli ingressi, le uscite, gli orari, le ferie, la definizione stessa di rapporto di lavoro – non c’entrano col fordismo, c’entrano con la storia delle relazioni industriali. L’istituto legato al fordismo è invece l’inquadramento unico, che ha lo scopo di classificare i posti di lavoro. L’inquadramento non inquadra le persone, ma inquadra i posti di lavoro, che sono di prima, di seconda o di terza, quindi tu sei di prima, di seconda o di terza. Oggi questi posti di lavoro sono sempre più diffusi, non dico che si disperdano, ma sono sempre più dei ruoli: fare il macchinista nella fabbricazione di patatine vuol dire controllare tutta una serie di macchine, non c’è un posto.
Il concetto di posto sta sparendo. Il posto è quello della catena di montaggio in officina o della mia scrivania in ufficio, ma se io devo seguire quattro o cinque macchine, c’è già un concetto di ruolo che riporta la professionalità sulla persona non sul posto. Dunque l’inquadramento unico è vecchio, perché classifica i posti non le persone, sembra che parli di persone in realtà si riferisce ai posti. È soltanto una griglia. Ci sono ancora i posti base, come l’operaio alla catena di montaggio, però col tempo si è aggiunta tutta una serie di cose che i contratti non riconoscono. Per cui uno è classificato in base al posto di lavoro da cui è partito, ma tutto il resto intorno non è riconosciuto: non c’è fabbrica oggi dove non si discuta della polivalenza, però non è scritta sul contratto di lavoro. Ecco dove i contratti nazionali andrebbero riformati».
Lei considera il coinvolgimento dei lavoratori il punto debole, il tallone d’Achille dell’introduzione del Wcm nelle fabbriche italiane: non ce n’è abbastanza. Quanto è uno scoglio questo problema?
«È uno scoglio enorme. Senza il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori, i progetti di innovazione organizzativa e tecnologica in atto nelle fabbriche, che a mio avviso sono già pochi, non raggiungono il cento per cento dei risultati che potrebbero raggiungere. Questo è il punto. Non è che il coinvolgimento sostituisca i progetti: i progetti ci devono essere, gli investimenti ci devono essere, ma un progetto che abbia potenzialità cento, senza coinvolgimento dei lavoratori potrebbe non andare oltre il 50 o il 60 per cento dei risultati, mentre con il coinvolgimento potrebbe avvicinarsi al cento per cento. Questi risultati vogliono dire più produttività, più qualità, risparmi dei costi».
Che cosa inibisce il coinvolgimento dei lavoratori nell’applicazione del World Class Manufacturing»?
«A mio avviso il reciproco sospetto fra i manager e i lavoratori, per abitudini che vengono dal passato, per eccesso di cultura gerarchica. Si immagina che l’innovazione venga comandata, ma non è mai così. Il manager dà il commitment, che è molto diverso dal comandare, poi l’innovazione vede protagonisti gli stessi manager, i tecnici, i capi, gli operai, dal manutentore all’operaio di linea. Sono loro che fanno l’attività organizzativa. In più l’Italia ha una storia di fazioni, di gruppi, di campanili e via dicendo, quindi fa fatica ad avere questo aspetto cooperativo, mentre altri paesi come Germania o Giappone hanno culture più orientate verso la cooperazione. Attenzione, non è che non siano conflittuali, però dosano differentemente conflittualità e cooperazione. Da noi invece prevale la tendenza a rapporti contrappositivi, invece che scegliere caso per caso fra conflitto o cooperazione».
È stata posta, su questo tema, una domanda curiosa: se c’è coinvolgimento operaio, con produzione di saperi operai, che favoriscono la produzione, ci potrebbe essere una questione di copyright? Come va riconosciuto il merito?
«Gli operai italiani hanno la sensazione diffusa di non essere ascoltati. In qualsiasi fabbrica lei vada, sentirà ripetere la stessa lamentela: da tanti anni diciamo che questa macchina non va, che questa cosa non funziona, ma nessuno ci dà bada. Insomma gli operai italiani sono i meno ascoltati del mondo. O almeno, questa è la loro percezione. Perché c’è una evidente prevalenza di cultura gerarchica e l’abitudine a non ascoltare, a ritenere stupido l’operaio, che era tipico del modello taylorista: l’uomo-bue che andava formato, secondo le esigenze della fabbrica. Può darsi che a quei tempi Ford e Taylor avessero ragione, però oggi non è più così. Ora la Fiat dice di aver ricevuto un milione di suggerimenti sull’applicazione del Wcm. Bene. Ottimo. Ma questi suggerimenti è chiaro che non sono pagati come non è pagata la polivalenza, non è pagata tutta una serie di attività, mentre l’operaio può rivendicare a buon diritto che ci sia un ritorno economico. Se le idee dei lavoratori producono miglioramenti, vanno pagate».
Il nuovo modo di produrre può essere oggetto di scambio fra imprese e lavoratori? In particolare cosa potrebbero rappresentare in questa logica gli orari a menù?
«Lo scambio c’è sempre. Anche nel Wcm è evidente. Lo scambio è questo: voi ci aiutate a migliorare, poi però il posto di lavoro è migliore. Evidentemente, nel mondo Fiat, gli operai fanno meno fatica, non si rompono più la schiena perché le postazioni sono studiate più ergonomicamente, i posti di lavoro sono più puliti e salubri, ci si fa meno male, mentre una volta c’erano molti più incidenti. Quindi è bello lavorare in una fabbrica che assomiglia a un laboratorio piuttosto che stare in una fabbrica dell’ottocento. Quindi lo scambio: migliore condizione del posto di lavoro, oltre che conservazione dello stesso, naturalmente, in compenso di uno sforzo partecipativo dei lavoratori.
Questo scambio, secondo me, può essere portato anche in altri contesti, che riguardino per esempio l’orario di lavoro. Io penso che l’azienda può avere più flessibilità se è disposta a concedere anche qualche flessibilità ai lavoratori. È insomma possibile un gioco a somma positiva. Normalmente si pensa che se l’azienda vuole un certo orario, allora le condizioni del lavoratore peggiorano. Viceversa, se il lavoratore chiede un certo orario, l’azienda rischia di andar male. C’è qualcuno che comunque ci rimette. Invece studiando la questione con pazienza certosina si possono trovare soluzioni di orario che vadano bene sia all’azienda che ai lavoratori».
Può fare dei casi? Per esempio come funzionerebbe per gli straordinari? Che, fra l’altro, è uno dei punti sempre conflittuali nelle negoziazioni.
«Se pensiamo a un orario uguale per tutti, per esempio un orario per mille lavoratori, è chiaro che si fanno i conti con esigenze tutte diverse: il giovane e l’anziano, chi ha famiglia e chi no, chi porta a scuola i bambini, eccetera. Ogni persona ha un’esigenza temporale propria, quindi se l’orario è uguale per tutti e viene imposto, ci sarà qualcuno cui va bene, qualcuno cui va male e qualcuno cui va malissimo. Infatti c’è gente che lascia il posto di lavoro perché non si adatta a un certo orario. Può succedere anche l’opposto: se lei chiedesse ai lavoratori il loro orario ideale, riceverebbe tante risposte diverse. Allora per combinare le esigenze dell’azienda con quelle dei lavoratori bisogna che le imprese trovino diverse forme di orario con cui far girare un certo impianto in una certa fabbrica.
Ovviamente ciò è possibile fino a un certo punto, però è ben noto che se la catena di montaggio va, diciamo, a due turni, la manutenzione può anche andare a turni diversi. Oppure posso avere reparti con organizzazione diversa: reparti a giornata, a due turni, a tre turni; quindi dovrei mandare nei reparti a tre turni quelli che vogliono fare la notte, nei reparti a due turni quelli che gli vanno bene i due turni, nei reparti a giornata quelli che gli va bene la giornata. L’idea dei menù è la seguente: se l’azienda ipotizza di far girare gli impianti con un menù di orari diversi, i lavoratori hanno in qualche modo una possibilità di scegliere, allora il lavoratore sarà più contento dell’orario, e quindi sarà meno assenteista, perché con un orario che ti aggrada risolvi i problemi personali più facilmente. Non solo: siccome per l’azienda flessibilità vuol dire lavorare un po’ di più nei picchi e stare a casa nelle fasi di bassa, che cosa potrebbe allora succedere? Che il lavoratore con un orario a lui favorevole diventa disponibile a lavorare un po’ di più nei picchi e un po’ meno nelle basse. Se faccio già un orario che al novanta per cento mi va bene, sono più disposto a adattarmi. Se viene incontro al lavoratore, l’azienda lo troverà disponibile a andare su e giù secondo i picchi stagionali».
Si può ipotizzare un Wcm del sistema territoriale? Questo nuovo modo di produrre potrebbe avere delle ricadute anche sul territorio, non solo sulla competitività delle imprese, ma anche sul welfare territoriale, in modo da non disperdere all’esterno i risultati raggiunti all’interno?
«Possiamo immaginare un passaggio del sistema nelle reti di fornitura e subfornitura, e un pochino nelle reti dei servizi. Diciamo che anche nei casi migliori, come Fiat, il sistema è ancora in gran parte applicato dentro la grande impresa. Loro hanno cominciato a estenderlo alle subforniture, ma questa estensione è ancora limitata. Qui parliamo di aziende un po’ obbligate a applicarlo se non vogliono rischiare di uscire dall’orbita della grande impresa, ma sarebbe interessante che questi sistemi fossero estesi all’intero settore della piccole imprese, che potrebbero aumentare la loro efficienza adottando alcune delle modalità del Wcm.
I pillar applicabili alle reti sono quello logistico, quello della qualità, e qualcun altro, però non la totalità. L’altra cosa interessante sul territorio sarebbe applicare questi principi alla pubblica amministrazione. Può sembrare pazzesco ma non lo è. Ovviamente la pubblica amministrazione non si occupa di produzione materiale, ma per esempio si potrebbe evitare almeno la doppia manipolazione, se consideriamo che nella pubblica amministrazione lo stesso dato può essere manipolato anche decine di volte, con sprechi incredibili. Quanto al welfare, credo che una parte dei saving realizzati nell’ambito di un territorio potrebbero essere destinati a sostenerlo, soprattutto quando lo Stato non ha più tante risorse (come in parte sta succedendo in Luxottica e in Ferrero). Più in generale, c’è il tema della lotta agli sprechi, ingorghi, code, traffico bloccato, rifornimenti problematici. C’è già un certo parallelismo fra l’idea ecologica per uno sviluppo sostenibile e i principi di lotta agli sprechi del WCM. Sembrano mondi che non si trovano, non s’incrociano, mentre è solo problema di linguaggi».
Un’ultima domanda: che spazio resta, che ruolo vede per il sindacato?
«Vedo un ruolo enorme ma i sindacati fanno fatica a vederlo e coprirlo. Nella misura in cui il coinvolgimento delle persone è un elemento essenziale di questa storia, il sindacato è proprio le persone o dovrebbe essere le persone. Quindi nel momento in cui si chiede un maggior coinvolgimento dei lavoratori, il sindacato – che siamo noi – dovrebbe essere più partecipato più responsabilizzato, più presente. Anche perché qui non c’è una cancellazione dei ruoli: i padroni sono padroni, i manager sono manager, i capi sono i capi, gli operai sono gli operai, non c’è uno sconvolgimento di questi ruoli. L’operaio che diventa padrone, questo cambierebbe tutto. Ma qui i ruoli sono gli stessi. Il problema è un altro: il sindacato ha in mente un modello di fabbrica che non c’è più, quello fordista».